A questa domanda la risposta che sento più frequentemente suona più o meno così: "dipende dal fatto se una persona ha stile/gusto, ed è una cosa che si ha o non si ha".
Questo modo di vedere le cose a mio avviso contiene il giudizio che lo stile sia tout court sinonimo di eleganza e bello e che sia una dote o una competenza che o si possiede oppure non ci sia nulla da fare.
E se invece prendessimo il termine in modo neutro?
Prendo alcune righe dal dizionario, che così definisce lo stile: insieme dei mezzi espressivi che costituiscono l'impronta di una persona o un gruppo.
Guardandola in questo modo, ci rendiamo conto che uno stile lo abbiamo tutti, da chi si veste all'ultima moda a chi si dichiara totalmente analfabeta rispetto agli abiti.
Ciascuno di noi ogni giorno fa delle scelte su cosa indossare, il risultato contempla degli scarti e dei consensi, e prima ancora ci saranno state delle scelte riguardo a cosa acquistare e far entrare nel proprio guardaroba, anche in questo caso ci saranno stati capi scartati e capi scelti.
Il mio interesse è sempre stato di comprendere cosa fa sì che ciascuno di noi scelga proprio quello che sceglie e scarti altri elementi.
L'abito e l'habitus
L'habitus è un sistema di schemi di percezione, pensiero e di azione, che ciascuno matura nei diversi contesti di vita e che risultano prevedibili e durevoli. L'habitus rappresenta quindi il nostro stile di pensiero, relazionale e comportamentale che ci orienta (anche) in fatto di abbigliamento.
Ed ecco che se il mio habitus è fatto di:
- estroversione, velocità, competitività, desiderio di emergere, interesse per le cose belle e lussuose, il mio abito molto probabilmente sarà di pregio, formale o comunque elegante, con elementi status symbol.
- estroversione accompagnata da interesse per le relazioni, per il divertimento, la condivisione, la voglia di visibilità e di riconoscimento,è prevedibile che il mio abito sarà spontaneo, espressivo, creativo e originale.
- introversione, sensibilità, empatia, disinteresse per la mondanità e l'apparire, il mio abito è probabile che sarà comodo, casual, per nulla appariscente, al contrario discreto e sobrio.
- introversione, individualità, quasi avversione per la socialità, desiderio di stare al riparo dal frastuono dell'esterno molto probabilmente l'abito seguirà questo schema diventando poco interessante e utile se non per la sua funzionalità.
Tornando quindi alla domanda iniziale "perché ci vestiamo come ci vestiamo", la risposta per me non può che essere: dipende dall'habitus che ciascuno di noi ha sviluppato a partire da delle predisposizioni e attraverso le sue esperienze di vita e sebbene l'habitus sia prevedibile e durevole non è immutabile!
Piacersi dentro e/o fuori
Qui vorrei esplorare la relazione tra abito e habitus in termini di soddisfazione, vale a dire quanto ci piacciamo dentro e/o fuori.
Nei tratti in cui parlo di insoddisfazione non mi riferisco a una lieve insoddisfazione, bensì ad un livello già discreto che mette la persona che la prova in difficoltà. Le casistiche che ho avuto modo di osservare sono più o meno queste:
- a) piacersi dentro e fuori (ovvero essere soddisfatti di habitus e abito): in questo caso la persona si piace interiormente e si piace anche nell'abbigliamento, alla domanda "cosa vorresti di diverso nel tuo guardaroba" di solito la risposta è: "nulla mi piace quello che ho e che indosso", allo stesso modo c'è un riconoscimento delle proprie risorse e un buon livello di soddisfazione rispetto al proprio sé. Quanto al feedback esterno qui può capitare che sia positivo e dall'esterno venga riconosciuta la gradevolezza del look, in termini di eleganza, buon gusto, originalità, etc. Altre volte invece il feedback positivo dall'esterno non c'è, in questi casi la persona può rimanere indifferente ai commenti esterni e fedele alla sua soddisfazione, oppure essere spinta nella casistica seguente, che a breve vedremo.
In generale questa categoria è secondo me quella di chi, relativamente risolto, sa vedersi nella sua totalità, si apprezza, e si comunica in modo autentico e spontaneo. L'abito diventa una estensione, una manifestazione, un'espressione dell'habitus. - b) piacersi dentro ma non fuori (ovvero essere soddisfatti dell'habitus ma non dell'abito): qui per me rientrano in particolare due casistiche quella per la quale l'insoddisfazione verso l'abito è soggettiva e personale, e un'altra, quella a cui facevo riferimento nel punto precedente, nella quale la persona si piacerebbe ma viene indotta verso un cambiamento e in qualche modo la questione abito diventa "critica".
Entrambe hanno in comune la consapevolezza delle proprie qualità positive dal punto di vista interiore, del proprio valore, poi in un caso capita che la persona senta che quel valore non riesce a trasmetterlo attraverso l'immagine che vede come disallineata e priva di appeal.
Nell'altro caso invece la persona si piace o non ha un particolare interesse verso l'abbigliamento, perchè le cose importanti sono altre, o semplicemente perché è cresciuta in contesti che a loro volta non avevano cultura in merito, in questo caso la questione abbigliamento diventa "problematica" nella misura in cui si trova in ambienti che richiedono un certo livello di statement o dress code o c'è una crescita o un cambiamento che richiede anche un'immagine più "curata" o c'è qualcuno di molto vicino (un partner, un familiare, etc.) che esprime opinioni spesso non richieste o fa esplicitamente richieste di cambiamento dell'immagine perchè non rientra nel suo gusto personale.
Questa categoria è dunque quella di chi da un lato chiede all'abito un upgrade dell'immagine per fare un miglior servizio alla propria persona, dall'altro chiede di bilanciare qualcosa che manca (es. maggiore professionalità, standing, etc). In termini psico si parla di completamento simbolico del sé. - c) non piacersi né dentro né fuori (ovvero essere insoddisfatti dell'habitus e dell'abito): qui c'è un effetto alone che va dall'interno verso l'esterno e viceversa per cui la persona si sente incapace, priva di qualità e naturalmente con un'immagine inadeguata.
Qui la condizione a mio avviso merita ascolto, e rimando la trattazione al termine dell'articolo. - d) piacersi fuori ma non dentro (ovvero soddisfazione per l'abito ma non per l'habitus): su questo punto mi sono confrontata con un piccolo campione, una ventina di persone (18 donne e 2 uomini). Ho coinvolto il campione perché personalmente non ho mai osservato la situazione di chi sia realmente soddisfatto di come si veste, ma non della propria dimensione interiore. Quello che più volte mi è capitato di osservare è di vedere qualcuno che a fronte di una bassa considerazione di sé, se vestito e truccato da professionisti si vedesse bene e risultasse soddisfatto nell'immediato dell'immagine restituita dallo specchio, ma dovendo poi replicare gli stessi look in momenti differenti l'effetto non era più lo stesso, come se sentisse un'aura di inautenticità.
Oppure mi è capitato di osservare situazioni nelle quali a fronte di un feedback positivo largamente condiviso dall'esterno sull'abito, questo non fosse sentito dalla persona che vittima di insoddisfazione verso l'habitus non faceva suo il piacere della propria immagine.
O ancora una iper attenzione al look il cui risultato era buono per la persona ma che sosteneva un costo molto alto, in termini di controllo, impegno e tempo e che per questo non mi sembra possa essere soddisfacente nel processo.
Tornando al campione intervistato, a fronte della domanda: "conosci qualcuno che si piace esteriormente, soprattutto per come si veste, ma non si piace per le sue caratteristiche interne, cioè si sente adeguato nel look, ma ha una bassa considerazione di sé" in generale il campione ha dichiarato la difficoltà di rispondere perché se da un lato è più facile avere un'opinione sulla dimensione interiore, risulta più difficile comprendere se realmente una persona si piaccia nell'aspetto estetico, in ogni caso 16 intervistati hanno dichiarato di non conoscere nessuno rientrante nella casistica, 4 hanno dichiarato di avere in mente alcune persone che vi rientrano, argomentando un po' la risposta in alcuni casi è riscontrato il piacere di vestirsi bene, o il percepire capacità, competenze nell'ambito (es. viene facile creare abbinamenti) o comunque la capacità nell'ambito non è in discussione, qualcun altro ha rilevato che l'aspetto è curato in modo quasi maniacale o sembrerebbe quasi una facciata per compensare delle carenze.
Queste ultime considerazioni si accordano con il concetto di completamento simbolico del sé di cui accennavo sopra (quando ci sentiamo carenti/incompleti usiamo gli oggetti per completarci) così come quello delle autostime specifiche, vale a dire posso sentirmi adeguata in un ambito, in questo caso quello corporeo, e magari non in quello sociale.
In questo caso l'abito pur non incidendo in modo sostanziale nella visione della dimensione interna, può essere usato come elemento dal quale partire per prendere consapevolezza sulle proprie risorse con un movimento dall'esterno verso l'interno.
Aumentare il livello di soddisfazione
Cosa possiamo fare per aumentare il nostro livello di soddisfazione verso le due dimensioni? Perchè direi che possiamo essere concordi nel dire che piacersi dentro e fuori sia la meta verso cui tendere!
Possiamo lavorare dal di dentro con percorsi che vanno dalla consapevolezza, alla crescita personale, sino alla terapia, e abbiamo visto che quando ci piacciamo dentro tendiamo a piacerci anche fuori, la soddisfazione per il proprio habitus è un requisito necessario ma non sempre sufficiente per stare bene nei propri panni (vedi casistica b) e questo perché non siamo monadi, isolate dal resto del mondo siamo in relazione, in confronto, e soggetti a influenze sociali, quanto più siamo in contesti che ci rispecchiano in termini di valori, interessi, bisogni, etc. ecco che davvero habitus e abito vanno a braccetto e diventano l'indicatore che stiamo proprio vestendo i nostri panni e il dentro e il fuori sono coerenti, autentici e armonici.
Oppure possiamo lavorare dal di fuori, individuando i vestiti nei quali ci sentiamo bene, spingendoci un po' più in là delle nostre consolidate abitudini, osando, fidandoci del feedback che ci arriva dall'esterno e vedere l'effetto che fa un cambio d'abito sull'habitus.
O ancora possiamo usare l'abito come indicatore per misurare il nostro livello di benessere, soprattutto quando un cambio d'abito ci viene richiesto dall'esterno perché da un lato può essere un' occasione di crescita, miglioramento e sviluppo di potenzialità che ancora non avevamo intuito, dall'altro può essere qualcosa che ci allontana da noi, può essere il campanello che ci invita a chiederci se è realmente quello che ci corrisponde e in linea con chi siamo.
Domande che tornano utili
Infine concludo questo articolo con alcune domande che possono tornare utili per lavorare su di sé attraverso l'abito
- Sono soddisfatta della mia immagine?
- C'è qualcosa che vorrei di diverso?
- Ci sono dei feedback positivi che ricevo e che possono ispirare un cambiamento?
- Cosa mi piacerebbe indossare che non indosso?
- Cosa potrei iniziare a sperimentare,da questo momento, di nuovo per andare verso il cambiamento che desidero?




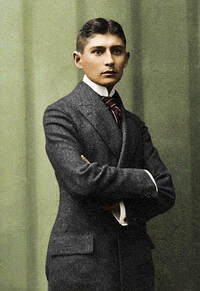





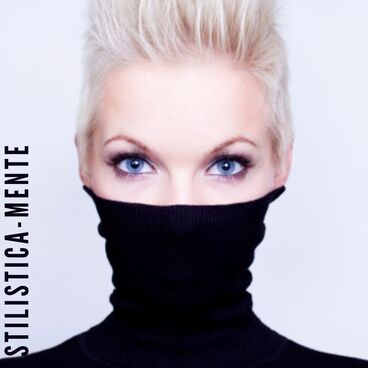
 Feed RSS
Feed RSS
