L’elemento centrale nella buona riuscita del suo uso sta nell’allineamento delle intenzioni dell’emittente e delle interpretazioni del ricevente, in quest’ottica può essere usato come linea guida nella costruzione dei propri outfit usando strategicamente forme e colori allineati con l’obiettivo e il risultato che si vuole ottenere.
Semplificando molto, giusto per dare degli esempi, se voglio farmi notare utilizzerò il colore rosso, se voglio essere trasparente il colore grigio, se voglio dare l’immagine di ordine, precisione e rigore opterò per un pattern rigato, se voglio creare simpatia e vicinanza un pattern a pois e ancora se voglio mostrarmi giovanile e dinamica sceglierò delle scarpe da ginnastica, se voglio dare l’idea di femminilità una scarpa con il tacco.
Se conosco un po’ il contesto e gli interlocutori che interagiranno con me ci sono buone probabilità che il messaggio sia interpretato come da mie intenzioni.
Il lessico, ad una prima impressione, potrà anche mentire o meglio veicolare messaggi che possono depistare, ad esempio vestendomi di colori chiari e luminosi e pattern curvilinei comunico che sono una persona aperta e socievole ma invece magari nel mio io sono chiusa e riservata.
Tuttavia il punto sul quale voglio soffermarmi è un altro, perché ritengo che le opportunità maggiori, quanto all’uso, il lessico dell’abbigliamento le offra nel dire a Sé e nel permettere di agire nelle migliori condizioni nei propri contesti.
Poniamo il caso che voglia mettere le distanze tra me e l’interlocutore perché lo ritengo invadente e ho bisogno di sentirmi protetta, potrò scegliere dal mio guardaroba un colore scuro e profondo come il nero, angoli e punte nei pattern o nel taglio dei vestiti, tessuti corposi con una vestibilità accollata.
In linea di massima, come detto poco sopra, ci sono buone probabilità che il messaggio arrivi al mio interlocutore ma anche nel caso così non fosse, perché la sua soggettività o la sua cultura creano una forbice molto ampia tra le sue interpretazioni e le mie intenzioni, il potere degli abiti si manifesterà comunque nella comunicazione intrapersonale.
La suggestione che voglio lasciare è quindi di non trascurare i propri bisogni, le proprie caratteristiche personali e certamente gli obiettivi ben formulati e allora gli abiti saranno i nostri più preziosi alleati.




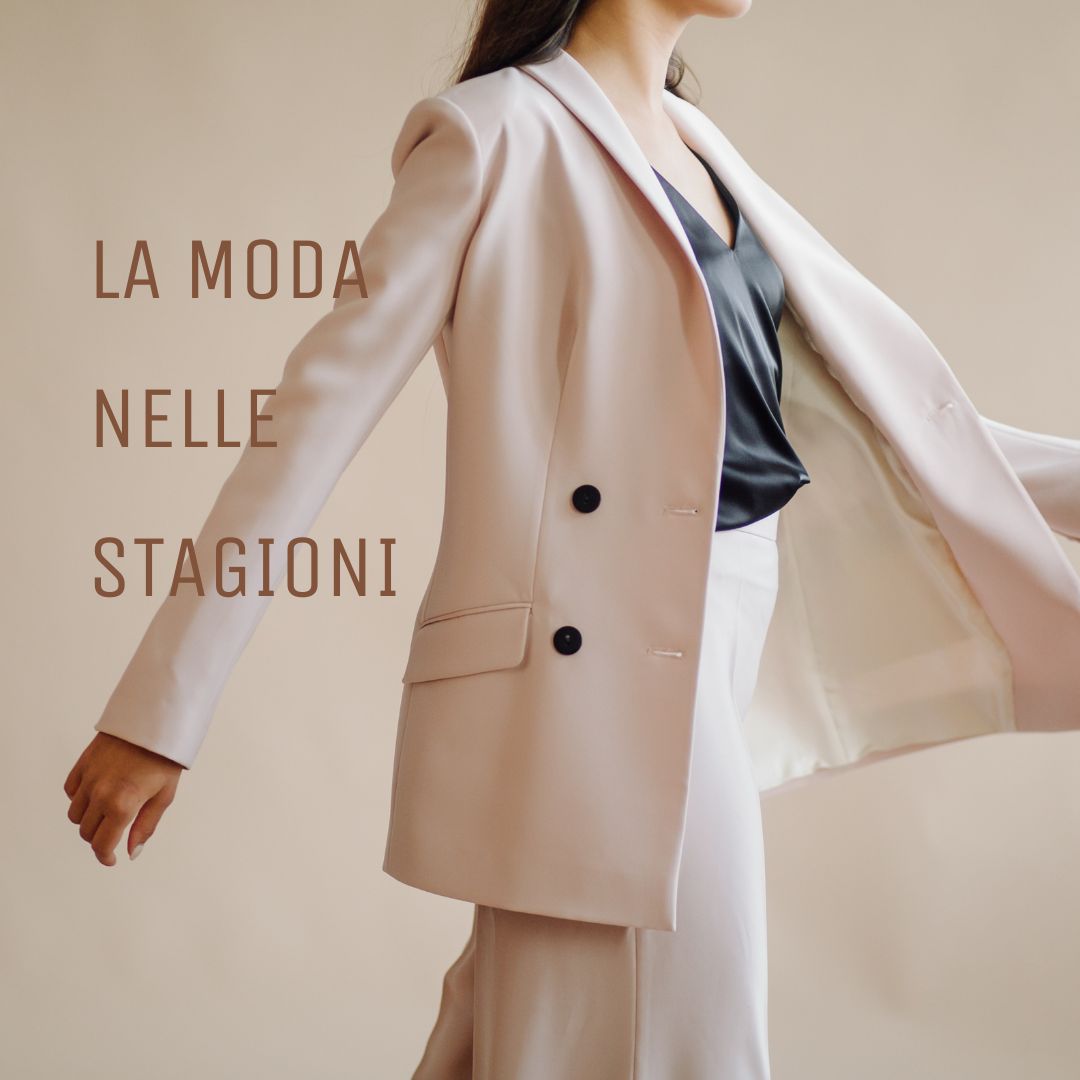
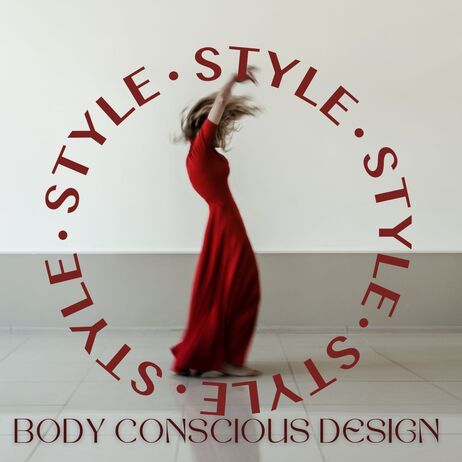

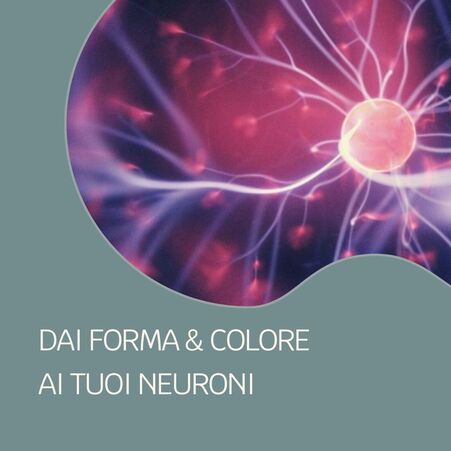


 Feed RSS
Feed RSS
